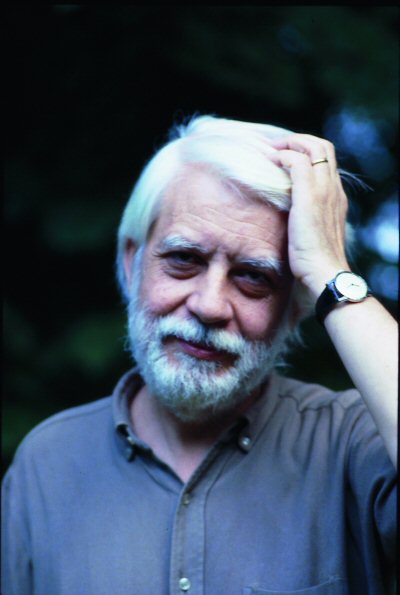Quando
scrive, Marco Belpoliti, rispetto a ciò di cui parla, – anche se in ogni cosa è
sempre dentro, perché non parla mai, neppure se richiesto, di qualcosa che non
ama o non lo interessa, che è poi la stessa cosa, almeno per lui – di
solito fa un passo in fuori, per vedere
meglio le connessioni, le differenze, le sfumature, i rimandi, le implicazioni,
come un geografo, o come uno studioso-camminatore che si ferma a guardare da
una terrazza o da una gobba della campagna, o al massimo da una collinetta; e
allora in ogni cosa lui c’è, ma è come se si sottraesse, come se non volesse
che si noti nemmeno qualche lembo della sua ombra come ogni tanto i fotografi
hanno il vezzo di lasciare intravedere nelle loro immagini, mentre invece, a
ben guardare, a non lasciarsi trascinare dalle molte cose che ci racconta e
descrive, da tutte quelle illuminazioni e curiosità che ci dona e ci fa
scoprire, lui dentro c’è sempre tutto, corpo e ombra, perfettamente mimetizzato,
come una farfalla o uno di quegli insetti la cui storia ci racconta in tanti
suoi articoli e libri. Nel suo ultimo, bellissimo libro invece, Pianura,
appena uscito da Einaudi, a me sembra che Marco il passo lo ha fatto in avanti,
dentro la materia e la scrittura, in primo luogo per l’inconsueta scelta, per
lui, della narrazione come carattere
primario, perché raccontare racconta sempre anche negli articoli e nei saggi, e
della prima persona come voce narrante, che si rivolge a un “tu” che prende la
forma, come personaggio, di un amico di lunga data con cui il narratore ha
condiviso, e condivide, molte esperienze, ricordi e interessi, oltre che un
ampio epistolario di cui il libro finge di entrare a far parte, ma che potrebbe
anche essere il lettore, soprattutto uno come me, che ne condivide la nascita e
la vita in pianura, se non il luogo di origine preciso, che pure nell’economia
del discorso, e della vita, e io lo so benissimo quanto a me, conta tantissimo;
e poi perché il racconto parte dal vissuto e dalla memoria, pur senza farne il
proprio oggetto principale – perché quello è sempre fuori, ma un fuori visto da
dentro; anzi, con dentro il proprio dentro, sparpagliato sulla superficie della
pianura e che in essa si riflette... –, forse anche a causa degli anni che
passano, che magari non pesano, ma ci sono, e ogni tanto fanno sentire la
propria voce, e allora, invece di difendersene e respingerla come sempre, fosse
solo per pudore, la si sta ad ascoltare, lasciandosene trascinare (incantare),
senza vergognarsi della sua dolcezza. Della sua tenerezza, che secondo me di Pianura
è il tono dominante. Assieme all’affabilità e alla confidenza che rivolgersi a
un amico consentono e che Marco in questo libro orchestra magistralmente, senza
smancerie e viceversa senza le forzature che in questi registri sono sempre
dietro l’angolo, traditore.
E
questa voce parla di ricordi, e di progetti, di viaggi, incontri, figure
famigliari, tanti amici, e tanti maestri, assiduamente frequentati o incontrati
poche volte in carne e ossa o mai, ma che hanno lasciato il segno, che vanno a
disporsi come nei riquadri della centuriazione romana che scandisce la piana
almeno fino al Po, e in certi casi oltre, a disegnarne il paesaggio anche
quando non sono più percepibili.
E
allo stesso modo, quasi senza darlo a vedere, anche da questo libro viene fuori
una vita, la trama larga e forte di una vita che non è solo di chi scrive, ma
anche la nostra, di molti se non proprio di tutti, di una generazione nata
negli anni ’50 e nella pianura e lungo i suoi fiumi, e un po’, ne sono certo,
anche quella di molti altri. Figure memorabili, note e quasi sconosciute,
raccontate in ritratti altrettanto memorabili, da Camporesi a Celati, da Berger
a Scabia, da Marco Martinelli e Ermanna Montanari a Benemerita Annarella e
Giovanni Lindo Ferretti, che vengono a compore, in filigrana, un’autobiografia
intellettuale e sentimentale, un autoritratto per interposte persone,
attraverso le predilezioni, le consonanze, le forme che la relazione affettiva
assume, come un esoscheletro che nasconde e insieme rivela il corpo che vi è
racchiuso, o come quei quadri di Arcimboldo che raffigurano persone o mestieri
o stagioni attraverso gli oggetti della loro attività o le loro caratteristiche
o i loro prodotti ma senza la loro speciosità, o la loro voglia di stupire,
perché leggendo li si vede ad uno ad uno e solo alla fine si riesce a intuire,
sottile, un tracciato coerente e unitario, appena accennato ma a quel punto
evidente e indimenticabile. Se questa autobiografia è tutta “esterna”, con
minime concessioni all’interiorità e al privato, è perché tutta esterna è la
biografia, proiettata verso il fuori, gli altri, i reciproci rapporti, che poi
vengono ripresi all’interno, sezionati e triturati e impastati nelle parole
(per usare metafore relative al cibo, che è uno dei motivi ricorrenti del
libro), perché è l’interno, sono gli affetti, il legante che li fa essere e
durare, per quanto dispersi siano nello spazio e nel tempo. L’andirivieni nella
pianura infatti avviene nel tempo oltre che nello spazio, con soste nei luoghi
segnati da frequentazioni, letture, immagini, viaggi, studi e memorie personali
e famigliari, che il lettore può seguire anche attraverso una mappa disegnata
da Belpoliti e riprodotta nei risguardi all’inizio e alla fine del volume, a
segnalare che il percorso era già iniziato prima della prima parola e non è
terminato dopo l’ultima, che non a caso, anch’essa scritta a mano, disegnata
come i tanti disegni che lo costellano: abbozzi, promemoria, scarabocchi..., è
“eccetera”.
Perché
la pianura comincia che è già tempo, è già storia. Nella sua geografia, e non
solo nella sua geologia, il passato è presente e visibile. Il libro lo dice
espressamente fin dall’inizio, con un capitolo dedicato alla centuriazione ancora
oggi riscontabile in larghi tratti soprattutto a sud del Po, e alla sua riscoperta
da parte di uno dei personaggi marginali e improbabili che costellano la
narrazione e contribuiscono al suo fascino: un soldato e console danese, in
questo caso, che fa la sua scoperta in Tunisia e poi cerca e trova tracce e
conferme nella nostra pianura. Si nasce in uno spazio già misurato, diviso,
lavorato, che contiene nella sua superficie le stratificazioni che ne hanno
determinato i lineamenti. L’unico spazio che non cambia è quello che cambia
sempre, il cielo, con le sue luci che avvicinano o allontano le cose come
lenti, anche se per rendersene conto è necessario un limite, come quello delle
montagne che però non sempre sono visibili, perché spesso l’aria stagna, umida,
quasi densa certi giorni, diafana, persino opaca anche in assenza di nebbia; il
cielo a sua volta cartografato da Ghirri, autore della stupenda foto della sovracoperta,
con le sue nubi e velature, ma senza indicazioni né altro indizio che non sia
quello della cornice dell’immagine. Pianura è un libro di cartografi
scritto da un cartografo. Cartografi di territori reali e immaginari, come il
trecentesco monaco visionario Opicino, o di spazi che solo lo sguardo dettagliato
di chi vive a contatto del terreno può avere.
Nella
pianura lo sguardo dall’alto è impossibile, ci si eleva solo di poco, si è
sempre raso terra, tra le cose, una di loro. Lo sguardo è sempre orizzontale,
l’unica lontananza è l’orizzonte, se non ci sono case o alberi a impedirlo, ma
mobile a seconda dell’aria, lontanissimo col sereno. E il cielo, che allora è
facile popolare di fantasie. (Per questo è bello, ogni tanto, salire in
montagna, o a Bergamo alta, per me, e da lì, se c’è vento a spazzare lo smog,
vedere tutta la pianura, dall’alto, e se si è fortunati arrivare con lo sguardo
fino all’altro confine, gli Appennini, azzurri. Ma di solito, ci sono i paesi
nella caligine, i fumi colorati, qualche macchia di verde residuo, i margini
slabbrati della campagna, della visione. Dall’alto, ma, ancora, non da troppo
da troppo in alto.)
Ma
facciamo un passo indietro, a imitazione di quello di Marco, perché anche a noi
piace guardare come sono fatte le cose, come si articolano tra di loro e come funzionano:
il suo è un farsi indietro abbastanza da poter guardare da fuori, ma non troppo,
senza la pretesa di dominarle, a differenza delle presuntuose vedute aeree
della scienza. No, Belpoliti di solito fa un passo indietro, o due o tre,
quanto basta, per non perdere il contatto, come non lo perde mai dai libri
delle sua biblioteca, anch’essa sparsa sul territorio, e dalla sua memoria di
essi, le cui tessere sembra che vadano a comporsi da sole nei suoi saggi e
articoli e libri, a formare però quello che non è un mosaico ma un affresco,
perché le tessere lì dentro si scontornano e trapassano l’una nell’altra fino a
fondersi senza soluzioni di continuità, non più singolari, ma insieme.
Spiccano, ma come un insieme. Infatti, e questo a me piace molto, non cercano
di colpire nella loro singolarità, non vanno a caccia della memorabilità e della
citabilità anche quando potrebbero ambirvi. Sono disposte nel continuum della
discorsività orizzontale, unite con saldature invisibili, incastrate alla
perfezione come gli intarsi magistrali del duomo di Bergamo disegnati da
Lorenzo Lotto. Entrano nella rete della mente del lettore senza voler
colonizzarla, nemmeno con la malizia capziosa della seduzione, o illuminarla
con un eccesso di watt, bensì come luce diffusa, morbida, che accende nuove diramazioni,
che mostra o traccia nuovi percorsi, che poi, a posteriori, sembrano, e non
erano, già lì, portate da un movimento che le avvolge e le ordina senza fatica,
per quanto varia sia la loro natura e distante, per il senso comune, la loro
provenienza. Per vedere come questo procedimento funziona, basta prestare
attenzione al modo in cui sono costruiti i singoli capitoli, per esempio in
“Pispiò” dove la forma, l’andatura e la tonalità del discorso mimano il parlato
con le sue divagazioni e i suoi salti, e sono invece il risultato di un
meccanismo perfettamente costruito, compatto e unitario proprio laddove si
assume sembianze ramificate e dispersive.
Parlando
di Ghirri, uno dei suoi punti di riferimento, Belpoliti scrive che il suo
obiettivo non era di “denotare ancora una volta la trasparenza, ma piuttosto di
togliere tutta la trasparenza che c’è tra noi e il mondo, e questo per tornare
a vederlo. La nebbia assumerebbe questo compito di condurci alla visione del
mondo così come ci appare.” Chi vive nella pianura padana questa esperienza
l’ha fatta innumerevoli volte e anche se spesso non vi fa caso, ce l’ha dentro,
e la riconosce subito, se solo qualcuno gliela fa notare. Una cosa
difficilissima da realizzare in fotografia. Ora che tutti hanno uno smartphone,
lo possono sperimentare: anche quando sembra fitta, la nebbia nell’immagine
scompare, si sottrae alla vista quasi quanto sottrae alla vista il mondo. Personalmente
ho sempre amato la nebbia proprio per questo: che ti accoglie e avvolge, ti
nasconde e insieme ti espone all’ignoto, che è anche un pericolo e ti rivela a
te stesso; che mentre acceca regala visioni: le cose escono dalla nebbia e ti
vengono incontro nella loro singolarità e nella loro diversità, a seconda della
sua densità e delle “condizioni di luce” sulla pianura, per citare un altro dei
grandi amici e maestri di Marco, Gianni Celati, e a seconda dell’ora del giorno
o della sera, del fatto di ricevere il lume naturale o quello artificiale del
lampioni o dei fari di un’auto, come piaceva tanto a me, quando tornavo a casa
che era già sera e la nebbia era fitta e io prendevo apposta una strada che
attraversava la campagna buia, senza una casa e un lampione per chilometri e
chilometri, tutta curve e piccoli avvallamenti, che si doveva percorrere
lentamente, attento a non uscire di carreggiata e finire in un fosso o contro
qualcuno cha sbucava all’improvviso a piedi o in bici, e gli alberi che la
costeggiavano, in certi punti, uscivano pian piano, uno alla volta, nerissimi,
spogli, meravigliosi, e a volte, quando la nebbia si alzava, era come infilarsi
in un lunghissimo tunnel di buio sopra e attorno, e chiarissimo davanti,
illuminato per qualche metro dai fari e con le robinie e i sambuchi che ti
accoglievano a gruppi, come ad abbracciarti, e il mondo era vivo e ogni cosa sprigionava
il suo incanto prima di sparire; o di giorno, quando le gocce acquistano coma
una tonalità dorata, che diventa scintillio quando la strada porta verso la
montagna e a un certo punto arrivi alla soglia in cui esci verso il fulgore del
sereno ma per qualche attimo sei avvolto da una polvere luminosa, accecante
come quando si sta per rivelare una divinità, e questa divinità è il mondo;
oppure ancora, ed è quella che preferisco, quando si cammina di giorno e tutto
è sempre e solo grigio, in sfumature che vanno dal ferrigno al cinereo, e si
vede poco o niente eppure si va avanti, quieti e sicuri anche se ci si perde, perché anche se non lo
si percepisce, si avverte l’eco del mondo e la sua forma e la sua consistenza e
la sua consolazione, nel tempo sospeso, ininfluente, dimenticato. Sensazioni e
esperienze che anche Belpoliti conosce e racconta nel suo libro. “Per questo la
nebbia, scrive Belpoliti, è lo stato perfetto in cui vedere [lo] spazio [della
Pianura]: l’aperto è incommensurabile e la nebbia non lo lascia guardare.” Il
mondo non è in agguato, si è solo ritratto, lui pure, un passo indietro
dall’evidenza. Dalla sua prepotenza, per delicatezza.
E
anche per questo gli uomini della pianura hanno sempre un che di fantastico, e
di strano, incline all’immaginazione e alla nostalgia, predisposti a quel
particolare stato che viene chiamato “magone” (descritto in uno splendido
capitolo), che persiste a dispetto di tutta la loro disposizione alla
razionalità e alla pratica concretezza del vivere quotidiano, e a volte, a
momenti o per lunghe stagioni, li inghiotte. La lunga schiera di scrittori
emiliani che dal Boiardo arriva a Delfini e poi a Celati, e a Cavazzoni e
Benati e molti altri, di cui Belpoliti parla in questo libro aggiungendosi alla
schiera, è lì a dimostrarlo. E immaginazione è “tutto quello che racconto qui.
Sono cose vissute, ma nella memoria, col tempo hanno preso una strana forma,
come di sogno, a volte”.
Anche
quando il discorso fila via, foealizzato sulle storie da narrare e le figura da
ricordare, lo sguardo e la mente si muovono in continuazione e perlustrano i
paraggi e le lontananze, e all’improvviso si insinuano un dettaglio,
un’osservazione, una considerazione veloci, ma che lasciano il segno, accendono
e velocemente spengono una lucina, perché la lettura ti trascina avanti, la cui
traccia ti resta nell’occhio e nella testa ai margini del flusso, per cui spesso
te ne accorgi soltanto dopo, quando sei già passato oltre, con un effetto
ritardato, così che rallenti e torni indietro a rileggere, per poi riprendere
con quell’immagine o la riflessione ben salde, ormai ineludibili, che si
irraggiano anche sul seguito e lo illuminano di luce nuova, mostrando aspetti e
sfumature che erano rimasti nell’ombra, o invisibili (come quella sulle scale a
p. 252).
Così,
di luogo in luogo, di figura in figura, Belpoliti, come dice lui stesso, chiama
a raccolta il passato remoto e recente, gli amici lontani o scomparsi e riesce
perfettamente in quello che, in una rara ammissione personale diretta (di
solito espone ciò che è più intimo
parlando degli altri o con le loro parole), era l’obbiettivo che aveva in mente
scrivendo questo che è il più bello dei suoi libri, “rimettere insieme i pezzi
sparsi della [sua] vita”.
L’ultima
scena è al cimitero dove sono sepolti i genitori. Pianura è un omaggio
anche a loro, una memoria discreta e un congedo. Quello che prende forma e
viene a consapevolezza quando il narratore si accorge di aver trascurato troppo
a lungo e quindi lasciato seccare e isterilire la madre dell’aceto lasciatogli
in consegna dal padre, che l’aveva invece curato per tutta la vita, nel
bellissimo capitolo intitolato appunto “Aceto”, come vero e proprio taglio del
cordone ombelicale, che però il racconto riannoda simbolicamente e appiana
nella dolcezza della malinconia.
Le
ultime parole del libro, prima dell’“eccetera”, sono “necessità” e “modestia”:
un doppio sigillo.
Questo articolo è uscito l'8 marzo 2012 su "Le parole e le cose", che ringrazio di averlo accolto, in particolare nella persona di Italo Testa.