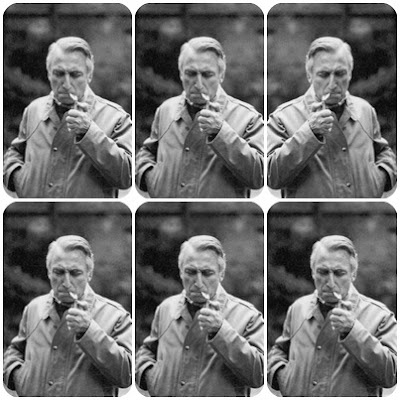Lo stadio di Wimbledon (07-08-1983)
Uomo
dei nodi, che si prodigava a intrecciare e a sciogliere; amico e consigliere
non solo letterario di scrittori, nei quali ha disseminato impronte in molti
casi di spessore inversamente proporzionale alla pubblica percettibilità;
lettore inesauribile prima ancora che professionale, alla costante ricerca di
novità e di capolavori misconosciuti; morto per suicidio, scelta sempre
fascinosa per gli altri, senza lasciare quell’opera che molti si aspettavano da
lui, e forse anche per questo aureolato presso i sopravvissuti, come capita, di
una sempre crescente fosforescenza numinosa, a Roberto Bazlen non mancava nulla
per diventare un ideale soggetto romanzesco. Gli mancava solo il romanzo. E
così quando Einaudi ha pubblicato Lo
stadio di Wimbledon del trentaquattrenne Daniele Del Giudice, che ha poi
meritatamente vinto il Premio Viareggio per l’opera prima di narrativa, è
sembrato che un’inspiegabile lacuna fosse finalmente colmata.
Ovvio
quindi che si siano subito occupati in molti del libro e che non siano mancate
rievocazioni e testimonianze su Bazlen e altri personaggi, attivi o appena
nominati, nel romanzo, come Gerti Ljuba Montale Svevo o Giotti, di suggestione
si troppo prevedibile per il cultore delle patrie lettere. Non so tuttavia
quanto alcune di queste testimonianze abbiano giovato al romanzo di Del
Giudice, perché non è sui quei personaggi che il libro, a dispetto di alcune
apparenze, è principalmente incentrato, e tanto meno è per essi che acquista in
interesse e rilevanza: evidenza che si impone molto presto al rammaricato
amante della biografia e dell’aneddoto, ma con felice sollievo al semplice
lettore che viene scoprendo un nuovo
autore di sicure qualità (è bene dirlo subito, derogando alle solite regole
cautelative, e un po’ pavide, che suggeriscono di non sbilanciarsi troppo con
le opere prime).
Lo stadio di
Wimbledon
non è un libro su Bazlen dunque. Questo non implica però che Bazlen sia solo un
pretesto: è la mediazione, o la deviazione, indispensabile al narratore per
raggiungere ciò che gli preme e per trovare l’accesso alla sua formulazione.
Soltanto in seguito a ciò Bazlen potrà non importare più (“Non sono mai stato
così vicino alla risposta, e così indifferente alla domanda”) ed essere infine
dimenticato come un problema che, quando “è vero, ed è risolto, può sembrare
non ci sia mai stato”. Anche se, allo stesso modo del pullover che Ljuba regala
al protagonista, qualche resto sussisterà comunque, e sarà importante: così, al
di là dei dati biografici, la complessità della figura di Bazlen e il profilo
dei vari interlocutori emergono ugualmente dalla narrazione, in modo insieme
accurato e evocativo.
La trama
del romanzo è costituita dal resoconto dei viaggi, a Trieste e nel sobborgo
londinese di Wimbledon, che il narratore intraprende nel desiderio di chiarire
le ragioni che hanno impedito a Bazlen di scrivere, ma che sono le ragioni che
spingono a scrivere lui, e la ricerca del “punto, in cui forse si intersecano
il saper essere e il saper scrivere”, ad interessargli veramente. Egli sa che
una vita come opera non compensa la mancanza di opera, o almeno non può valerne
da giustificazione; né d’altra parte gli sembra accettabile un’idea dell’opera
come sottrazione di vita. Sa anche che “scrivere non è importante, però non si
può fare altro”, perché il silenzio non permette “la falsità, o almeno la
probabilità, cioè la vita”.
Ed
è forse in questa disponibilità verso ciò che è virtuale, o meglio in
“un’intermittenza tra la probabilità e l’improbabilità”, che il punto di intersezione
consiste, in un atteggiamento che comporta un “sentimento di appartenenza a ciò
che è accaduto, o può accadere” e il “piacere di essere nel tempo e non contro
il tempo, di farcela rischiando tra le immagini, rischiando anche la propria,
lasciando che diventi una proprietà comune, modificata, viva...”.
Rischio
che il protagonista difatti assume, nonostante sembri preferire a volte
cancellarsi per ridursi a puro sguardo o a reticente interlocutore. Il realtà
la sua esposizione si effettua attraverso la proiezione nelle immagini e nelle
cose, e in una forma di distacco che, per evitare riflessioni psicologiche o
esistenziali, prende meno la forma dell’ironia, se non per ciò che è taciuto,
che dell’oggettivazione (no: “il viaggio”, ma: “il treno”, il trasporto
marittimo”, “le rotte aeree”). Se evita il coinvolgimento diretto e tutto gli
preme, ma non troppo; o, quando è costretto a esprimere opinioni, le smorza
regolarmente con formule dubitative, ritraendosi di fronte al definitivo, alla
sua stessa possibilità, è appunto perché non ignora che l’unico modo di
rischiarsi non è sopra le cose e le immagini, ma accanto e insieme ad esse, e
perché la probabilità, o la falsità, che è la vita non tollera ciò che è
stabile e definito una volta per tutte.
Ed
è anche per questo che raramente le varie questioni sono affrontate, o
approfondite, in modo diretto, e mai direttamente e con tono conclusivo vengono
enunciate le risposte, sebbene indicazioni anche molto articolate in tal senso
non manchino. La responsabilità della loro organizzazione viene lasciata,
coerentemente con il tenore del libro, a chi legge, indirizzatovi con mano
sapiente quanto leggera. Uso di proposito questo aggettivo perché “leggero” e
tutto il campo semantico confinante hanno un ruolo fondamentale nel testo e
nell’atteggiamento verso la realtà tipico della scrittura di Del Giudice, che
rifugge sia da una visione “troppo brillante e intenzionale”, sia dalla
frontalità monolitica o aggressiva. Il fatto è che tutto Lo stadio di Wimbledon è costruito secondo un principio che
potremmo chiamare di lateralità e una logica sospensiva: spostamenti, incontri,
discorsi e descrizioni, si susseguono con un rigore sì interno e visibile, ma
come se il fuoco del loro accadere e la necessità delle loro correlazioni
fossero sempre un po’ discosti, come se i loro significati più efficaci e
irradianti scaturissero da un’altra luce, che tuttavia non potrebbe
manifestarsi senza il supporto di quella loro propria. Non si tratta di
simboli, ma ancora di virtualità, che il complesso sistema di rispondenze
interne al romanzo, sia tematiche che stilistiche, mette in movimento e provoca
a stabilire: al pari della Carta di Mercatore, il cui “secondo nome è
Rappresentazione”, anche Lo stadio di
Wimbledon è “inventato con un calcolo preciso, e con una matematica quasi
perfetta”, un calcolo però del quale non è data chiave obbligatoria o una via
di interpretazione esplicita.
Non
si tratta di simboli, come dicevo, ed anzi la prosa di del Giudice si presenta
estremamente pulita e concreta: anche i paragoni si fondono impercettibilmente
con l’andamento descrittivo e narrativo, tanto più notevoli quanto meno di
originalità clamorosa. E’ la prosa di un occhio che ha come assorbito
l’intelletto, senza annientarlo ma rinunciando alle sue sicurezze, e che
persegue soltanto la logica della narrazione lasciando che tutto il resto si
profili, secondo un’espressione che Del Giudice utilizza in diverso contesto,
“nella leggerezza ironica della probabilità”.
Dalla
concretezza e dalla coerenza della narrazione emerge così una dimensione
teorica che le è insieme interna e esterna, ed è forse proprio in questa
capacità, che si manifesta in primo luogo nella coniugazione sintattica di
astratto e concreto, una delle caratteristiche più salienti di questo romanzo
che, come ipotizza Calvino nella sua bella quarta di copertina, riprende il
“romanzo d’iniziazione di un giovane scrittore” e insieme tenta “un nuova
approccio alla rappresentazione, al racconto”.
Atlante occidentale
(1985)
Vivere nel presente e vivere il
presente di rado coincidono; essere contemporanei della propria epoca, come è
noto, è sempre stato difficile, specie nei momenti di grande trasformazione:
tanto più, dunque, oggi. Oggi infatti la scienza ha fissato in regola la
trasformazione senza termine apparente, inducendo nel tempo un’accelerazione
tale da modificare, oltre che la sua percezione e cognizione, il suo stesso
statuto, del tutto eterogeneo a quello delle epoche passate. È la sua
caratteristica principale, la velocità, dei cui benefici godiamo e che tanto ci
affascina, a condannare al ritardo i nostri tentativi di adeguamento, ogni
volta spiazzandoli, e a renderci estraneo il suo nucleo quanto più siamo invasi
dai suoi effetti: non lo sentiamo nostro quanto più siamo suoi, cioè, e l’incapacità
di farcene una rappresentazione non solo si traduce nella deficienza a viverlo,
ma anzi ci fa arretrare verso concezioni nelle quali appunto la parvenza di
sicurezza offertaci è il segnale più evidente della nostra impotenza. Sembra
che si sia prodotta una divaricazione insanabile e che si allarga sempre di più
tra gli oggetti, i comportamenti e le situazioni ai quali il nostro tempo ci
lega, da una parte, e le immagini e i sentimenti che ne abbiamo dall’altra, ed
è un triste paradosso che la forse maggior responsabile sia la scienza nel
momento stesso in cui sembra avvicinarsi come non mai alle radici della materia
e della vita.
Il divario naturalmente non si colma
rincorrendo il progresso delle conoscenze scientifiche e dei suoi risvolti
tecnologici, quanto trovando un migliore rapporto con il mondo da essi in gran
parte determinato. E se la letteratura è quella forma specifica di conoscenza
che ha per oggetto la trasformazione nel tempo dei rapporti dell’uomo con il
mondo, delle immagini che se ne fa e dei sentimenti ancor più delle conoscenze
che ne ha, allora spetta ad essa affrontare questi problemi, facendosi carico
anche di quelli che la scienza pone e insieme approfittando delle prospettive
che essa apre e delle soluzioni che propone o prefigura.
Sono questi i problemi che affronta,
con decisione apri alla lucidità con cui ne definisce i presupposti, Atlante occidentale, secondo romanzo di
Daniele Del Giudice, che non solo conferma le ottime qualità già evidenziate
nel precedente Lo stadio di Wimbledon,
ma ne riprende anche, a dispetto delle cospicue differenze di trama
ambientazione e personaggi, i temi di fondo, spostando e allargando la
prospettiva fino a chiudere, anche teoricamente, la traiettoria inauguratavi.
L’indagine sul rapporto tra saper essere e saper scrivere, che nel libro d’esordio era condotta secondo
preoccupazioni prevalentemente personali che di fatto privilegiavano l’ottica
della scrittura e il problema della rappresentazione, viene infatti ripresa in Atlante occidentale dal versante opposto
e con ambizioni più generali. Il problema del saper scrivere viene cioè
subordinato a quello del saper essere, e anto la ricerca di modelli di
rappresentazione quanto l’analisi dei sentimenti e delle relazioni “ degli
uomini tra di loro e con gli oggetti confluiscono nella necessità di vivere
meglio il proprio tempo. D’altra parte tale confluenza, invece di sminuire
l’importanza della scrittura, le conferisce una legittimazione “oggettiva”,
valorizzando contemporaneamente anche le procedure e gli oggetti che dalla sua
tematizzazione emergono.
In
tal modo però ciò che sembrava solo funzionale torna in primo piano, e il libro
si rivela in piena luce per quel che di fatto è: la definizione di una poetica
attraverso la propria esemplificazione. Ipotesi e insieme verifica insomma,
definizione in qualche modo conclusiva prima di passare ad altro:
consolidamento delle basi, anzi, appunto per poterlo fare. Lo rivela del resto
anche il dialogo finale tra i due protagonisti: “È una giornata di molte
novità, per me e per te.” – “Bene.” – “E adesso?” – “Adesso dovrebbe cominciare
una storia nuova.” – “E questa? – “Questa è finita.” – “Finita finita?” –
“Finita finita.” – “La scriverà qualcuno?” – “Non lo so, penso di no.
L’importante non era scriverla, l’importante era provarne un sentimento.” (A
proposito di quest’ultima informazione è appena il caso di rivelarne il
carattere ironico, dato che importante è invece che qualcuno l’abbia scritta e
che il sentimento più che i personaggi lo provino i lettori: il che però non è
scontato.)
Anche la scelta dei protagonisti appare
funzionale al carattere programmatico e “manualistico” del libro, già indicato
peraltro dal titolo (l’atlante è infatti una raccolta di immagini che
definiscono degli spazi o, più generalmente, di rappresentazioni di una data disciplina, e il manuale è un
compendio di nozioni fondamentali e
di istruzioni relative a una data
attività, il cui fine non a caso Del Giudice sostiene essere “uno solo,
accrescere la felicità del genere umano”). Se infatti la scienza determina le
maggiori trasformazioni della vita nel nostro tempo e la letteratura, come si
diceva, queste trasformazioni in relazione all’uomo ha per oggetto,
protagonisti del libro non potevano che essere uno scienziato (e anzi un rappresentante
di quella che oggi è la scienza guida, la fisica atomica) e uno scrittore (per
quanto alla fine della carriera e alle prese con il problema di uscirne con
felicità: una figura che, sia detto per inciso, fa da contraltare a quella di
Bobi Bazlen nel primo libro).
Dell’incontro, dell’amicizia, di
discorsi e delle riflessioni di questi due personaggi, e cioè del giovane
fisico italiano Pietro Brahe e del vecchio scrittore ebreo-tedesco Ira Epstein,
parla principalmente Atlante occidentale,
mirando però alla delineazione di una mappa
di sentimenti, percezioni e comportamenti che concilii le istanze, generalmente
sentite come alternative ma per Del Giudice complementari, da essi incarnate
(non solo scienziato/scrittore, ma anche giovane/vecchio; italiano/straniero,
anche se di cognome straniero l’uno, e straniero per eccellenza, ebreo, ma che appunto
per questo sa trovarsi a casa ovunque, l’altro, e comunque ambedue con salde
radici nell’occidente; esperto delle teorie/esperto dei comportamenti concreti,
ma ambedue esperti del visibile, sebbene l’uno al di sotto e l’altro al di
sopra della soglia normale, con la quale tuttavia ricercano un’integrazione
armoniosa; ecc.).
Il romanzo si dispone così
contemporaneamente su più piani, ciascuno dei quali rimanda all’altro ma
insieme reclama la propria sufficienza e autonomia (la storia, la mappa, la
teoria; l’esempio, l’inquadramento, la giustificazione), ma questo, se ne
costituisce il fascino e anche la forza, ne segna d’altra parte anche il
limite, del quale certamente Del Giudice era consapevole, preferendo tuttavia
assumerlo piuttosto che accontentarsi di poco. Ne viene a soffrire infatti
quello che dovrebbe essere, in un romanzo, il piano fondamentale, la narrazione
che dagli altri resta in più di un’occasione condizionato per eccesso di
funzionalizzazione: allora eventi, riflessioni e gli stessi personaggi appaiono
schematici e predeterminati, come svuotati dal carico esorbitante loro imposto,
e la misura del sentimento, che pure dovrebbe essere essenziale, decade a
valletta della geometria intellettuale che tutto deve far quadrare, rivelandone
le debolezze. La tentazione dell’armonia rende tutto troppo dolce, leggero,
vaporoso; non c’è più traccia di contraddizione, l’idillio regna e il cerchio
si chiude: Brahe e Epstein non mancano l’ultimo incontro, nella medesima notte
all’uno riesce finalmente l’esperimento e all’altro viene assegnato il premio
Nobel e i trenini sul plastico che Epstein sta guardando sono in perfetto
orario.