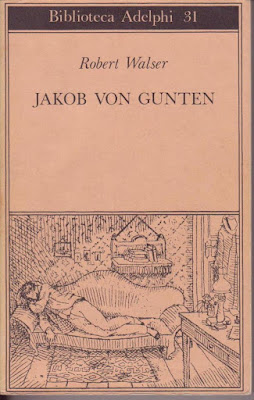Dicono
che ogni tanto Dio scendeva nell’Eden a fare quattro chiacchiere con Adamo. Si
vede che aveva bisogno di compagnia. O pensava che a sentirsi solo fosse Adamo,
pur in mezzo alle delizie del creato in cui si integrava benissimo, totalmente,
senza la benché minima frizione? Non si sa. Fatto sta che “scendeva” e passava
del tempo con lui. Io però non credo che chiacchieravano davvero. Si
intendevano in qualche modo, questo è sicuro, ma non a parole secondo me: con
qualche forma di comunicazione diretta, immediata, non linguistica quindi, come
Adamo già faceva con gli animali. Dicono che ne parlasse tutte le lingue, ma è
una panzana, gli animali non hanno mai parlato. Bastava che fossero l’uno di
fronte all’Altro e tutto era a posto. A me sarebbe bastato. Cioè, hai Dio in
persona che si è scomodato per venirti a trovare, di che altro potresti aver
bisogno?
Forse Dio
non scendeva nemmeno a “intrattenersi” con Adamo o a fargli compagnia, ma solo
per ammirare più da vicino la sua creazione. E per farsi ammirare, sussurrano i
maligni. Un Dio un po’ vanesio insomma. Un Dio narcisista. Ma tant’è, se lo può
permettere, Lui.
Forse Dio
ha creato Adamo solo per quello, da principio: uno che lo capisse, che godesse
della sua creazione, la ammirasse, e ammirasse il suo Creatore. Che gli
rendesse gloria. Anche questo a me sarebbe bastato. Lo avrei fatto volentieri.
Senza nemmeno essere sollecitato. Che a me cantare “in excelsis” tutto il
giorno basta e avanza.
Torniamo
a Adamo, però. Era di lui che stavamo parlando. Ammettiamo pure che sapesse
parlare, che nei momenti in cui se ne stava da solo nell’Eden si sia messo a
rimuginare tra sé mentre guardava le cose e le creature, e gli sia venuto il
gusto di mettere il nome a tutto quello che vedeva e sentiva. Ammettiamolo,
anche se l’ipotesi è peregrina, perché mettere un nome significa aggiungere
qualcosa, significa che vedi ogni cosa da fuori, che la tua fusione è
incompleta, che vedi te, o loro, o il vostro rapporto, come qualcosa di
incompleto, di imperfetto. Che Dio da qualche parte ha sbagliato qualcosa.
Ipotesi a cui mi rifiuto di credere. Ma ammettiamo pure che abbia giocato a
mettere nomi un giorno a questo un altro a quello. E poi? Si girava i nomi in
bocca, come una caramella, ripetendoli tra sé e sé per non dimenticarli? Per
parlare Adamo ha avuto bisogno di Eva.
Ma di
Eva, prima di Adamo, secondo me, ha avuto bisogno Dio. Secondo me Dio alla
lunga si è annoiato con quel bamboccio sempre così beato e contento di sé e di
Lui. Allora gli è venuta l’idea di togliergli qualcosa, di incrinare quella sua
perenne soddisfazione, e renderlo così più interessante. Così ha creato Eva.
Gli ha dato una compagna: gli ha aggiunto qualcosa, dicono. Lo ha completato
(lo avrebbe completato). Ma come si può completare qualcuno che è già completo?
Allora per farlo, gli ha tolto qualcosa. La costola. Era tutto così perfetto
che aggiungere qualcosa era impossibile, se non rendendo imperfetto qualcos’altro.
Anche lui a suo modo perfetto, dopo, ma con qualcosa in meno. Una perfezione
difettiva. Ma anche con qualcosa in più, tramite quel raddoppiamento identico,
con qualche piccola differenza. Due perfezioni che diventano una per via della
differenza che li separa. Ma due, comunque. Allora sì che le cose si sarebbero
messe in moto.
È stato a
quel punto che Adamo ha avuto bisogno di parlare. O piuttosto: che ha avuto
occasione di farlo. Che gli è accaduto di farlo. Con Dio non c’era bisogno (ma
d’ora in poi vorrei lasciar stare Dio, che tanto Lui non riusciremo mai a capirlo
lo stesso…); con Eva di fronte sì. Non subito magari, ma dopo un primo periodo
di prime, silenziose scoperte, che può essere durato anche anni, secoli,
millenni addirittura (chi li contava a quei tempi?), un bel giorno Adamo si è
ricordato di quel giochetto solitario, e mentre se ne stavano stanchi e un po’
sudati, con il fiato un po’ ansimante, all’ombra di un grande albero carico di frutti,
indicandone uno ha detto: “Mela!”. E ha sorriso. “Mela”, ha ripetuto Eva, con
un cenno di assenso, allungando la mando per cogliere il frutto più vicino. E
sarà che era ancora un po’ affannata, o che il gesto di assenso del capo abbia
prodotto spontaneamente un suono, o che sia stato il piccolo sforzo di
allungare la mano verso il ramo carico di frutti: “Sì, mela”, ha ribadito
sorridendo a sua volta. E quel suono è stato “Sì”. E secondo me è stato proprio
così che è nato il linguaggio.
Sì.
Uno
sbuffo, un soffio, forse lo stesso con cui Dio ha dato il via alla creazione e
ha insufflato vita nel fango che poi sarebbe stato Adamo, e che a quei tempi
stava per quello che per noi oggi è “sì”, l’approvazione con cui Dio ha messo
il suo sigillo alla creazione nel momento stesso in cui creava e giudicava buono
ciò l’azione e il suo effetto, il tutto ripetuto senza volerlo da Eva, ma come
se qualcosa in lei lo sapesse, il suo corpo, che presto avrebbe generato a sua
volta. Come se Dio, proprio e solo a Eva, avesse voluto apporre il sigillo di
chi crea, di chi dà alla luce qualcosa, qualcuno per cui, nato, la luce poi,
infine, ogni volta, è.
(Ma Eva mentre
con il suo sbuffo, con il suo “sì”, non essendo Dio, con lo stesso gesto
complesso composto da azione, parola, riconoscimento, risposta, istituisce il
linguaggio, nel farlo entrare nel mondo fa entrare, insieme ad esso, allo
stesso tempo, nello stesso momento, il male. Riconosce la parola come parola,
riconosce che tra la parola e la cosa c’è un legame e insieme una separazione,
c’è un legame nella separazione, fa in modo che i suoni prodotti da Adamo
abbiano senso e valore, istituisce la parola e il mondo che essa designa ma più
ancora fa essere, cioè lo crea, rendendosi così, senza saperlo, simile a Dio, e
subordinando il mondo al proprio volere e sapere, lo finalizza ai propri
desideri, e coglie la mela, riconoscendola come tale e decretandola così come
propria, per soddisfarli, e implicitamente per dimostrarlo. Per dimostrare di
essere come Dio, e pertanto di poterne fare a meno. Cosa che, allora, era
appunto il male. Ora non so. E non è molto diversamente da così, secondo me,
che anche il male è nato. No.)